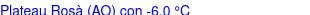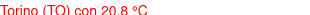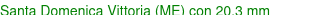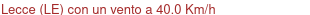La struttura dell'atmosfera rispetto alla temperatura
 La struttura atmosferica viene individuata e classificata in base allo stato tipico dell'aria alle varie quote relativamente allo stato fisico preso come riferimento. Nella realtà tale struttura verticale varia nel tempo e da luogo a luogo a causa dell'attività solare, delle varie posizioni e movimenti della Terra rispetto al Sole e dei cambiamenti delle condizioni meteorologiche.
La struttura atmosferica viene individuata e classificata in base allo stato tipico dell'aria alle varie quote relativamente allo stato fisico preso come riferimento. Nella realtà tale struttura verticale varia nel tempo e da luogo a luogo a causa dell'attività solare, delle varie posizioni e movimenti della Terra rispetto al Sole e dei cambiamenti delle condizioni meteorologiche.
Nel 1976 è stata definita l' "Atmosfera Standard", una rappresentazione ideale e statica di un'atmosfera considerata priva di vapore acqueo. Si tratta di una rappresentazione di comodo, una sorta di "media" di riferimento delle condizioni atmosferiche molto approssimata.
Per compensare il fatto che l'accelerazione di gravità g non è costante alle varie quote in quanto ci si allontana dal centro della Terra (il cui raggio medio è R0 = 6356.766 km) viene introdotta e definita l'altezza geopotenziale H:

I valori di P, T e ρ relativi all'atmosfera standard come funzione dell'altezza geopotenziale vengono riportati in opportune tabelle per la consultazione. Si può osservare che i valori di temperatura hanno un andamento lineare a tratti con la quota, cioè esistono alcune quote in corrispondenza delle quali tali linearità assumono entità e segni diversi. In particolare, fino alla quota di 51 km è possibile utilizzare le seguenti formule per descrivere l'andamento di P e T:
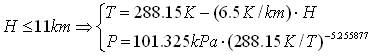
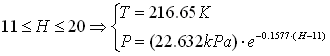
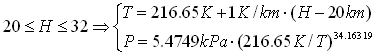
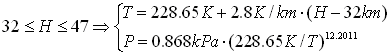
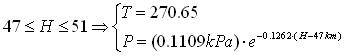
Una volta trovati T e P, la densità ρ può essere ricavata dalla equazione della legge dei gas ideali. Le formule descritte sopra sono migliori di quelle più generali viste nell'articolo dedicato allo stato termodinamico dell'atmosfera, perché in quel caso si assumeva la temperatura uniforme con l'altezza. Per un calcolo più preciso e più vicino alla realtà occorrerà usare la formula ipsometrica di cui abbiamo già discusso, che tiene conto del reale andamento della temperatura (ma in questo caso occorre conoscere il reale profilo termico verticale nel luogo e nel momento di interesse).
La Figura 1 riporta in forma grafica i risultati di quanto esposto in questo articolo. Notiamo che, sulla base dell'andamento a tratti lineare di T, si possono distinguere i seguenti strati dell'atmosfera standard:
0≤H≤11 km --> Troposfera (per H = 11 km --> Tropopausa)
11≤H≤47 km --> Stratosfera (per H = 47 km --> Stratopausa)
47≤H≤84.9 km --> Mesosfera (per H = 84.9 km --> Mesopausa)
H≥84.9 km --> Termosfera
La stragrande maggioranza dei fenomeni atmosferici avviene nella Troposfera.
Ma perché la T ha questo andamento tipico "medio"?
Ebbene tutto dipende da come la radiazione solare interagisce con l'atmosfera attraverso i fenomeni di assorbimento e conversione in calore dell'energia solare. In particolare:
- la luce visibile attraversa l'atmosfera senza quasi essere assorbita, ma arriva al suolo e agli oceani riscaldandoli. Essi poi riemettono l'energia assorbita sottoforma di radiazione infrarossa, rispetto alla quale l'atmosfera risulta invece opaca. E così l'atmosfera si riscalda dal basso, conferendo alla temperatura l'andamento che si osserva in Troposfera.
- arrivati in Stratosfera l'effetto prevalente non è dato dal riscaldamento dal basso (ormai troppo "lontano") ma dal riscaldamento che l'atmosfera subisce a causa dell'assorbimento degli UV (ultravioletti) da parte dell'ozono, abbondantemente presente a tali quote (massimo assorbimento intorno alla Stratopausa).
- in Termosfera, invece, l'atmosfera si surriscalda per assorbimento e interazioni con altre radiazioni.